Da "La domenica di Repubblica" del 26 novembre 2006
I GRAFFITI DEI DANNATI DELLA
GRANDE (santa!) INQUISIZIONE
Un libro di Maria Sofia Messana
"Inquisitori Negromanti e Streghe", racconta il lavoro della
mostruosa macchina repressiva
Il restauro di palazzo Steri, che
ospitò per quasi tre secoli
la "Santa Inquisizione" in Sicilia, e una
ricerca d'archivio
a Madrid ricostruiscono la vicenda seicentesca di Francesco
Mannarino, rinchiuso in quella prigione e autore
di uno
straordinario dipinto murale sulla battaglia
di Lepanto.
PALERMO
I pirati barbareschi lo rapirono in mare. Aveva tredici anni, fu portato
al mercato degli schiavi di Biserta e venduto a un raìs. Per salvarsi la
vita si convertì all'Islam. Era il 1600 quando Francesco Mannarino,
piccolo pescatore di Sant'Erasmo, finì come mozzo su una feluca corsara.
Ma in una giornata di tempesta la ciurma si ammutinò e Francesco tornò a
casa, a Palermo. Dal porto lo condussero dritto nelle segrete dove
imprigionavano eretici e bestemmiatori, idolatri, fattucchiere, maghi,
ebrei, maomettani, amici del demonio e negatori di Dio. E lì dentro, allo
Steri, il palazzo della Santa Inquisizione, rimase da
un'imprecisata notte di gennaio sino all' alba del 27 marzo del 1609.
Il ragazzo fu esortato ad abiurare la sua nuova
religione per ben due volte. Dopo le torture fu assolto, gli
raccomandarono però di "non fare più vita di mare" per non
cadere ancora nelle mani dei saraceni. In quei tre mesi di sottomissione
ebbe il tempo di disegnare su un muro della sua cella la battaglia navale
che — in tante traversate del Mediterraneo—i suoi sventurati compagni
gli avevano narrato: la flotta cristiana e quella ottomana, a Lepanto una
di fronte all'altra.
Quella scena, dipinta con i cocci frantumati e poi
legati al latte e all'albume d'uovo, è rimasta coperta per secoli sotto
un'incrostatura di malta grigiastra. Se oggi noi la possiamo ammirare e
soprattutto possiamo raccontare frammenti dell'esistenza del
"rinnegato" Francesco Mannarino e di altri settemilacinquecento
siciliani rinchiusi nelle carceri del Sant'Uffizio, lo dobbiamo all'anima
di un don Totò che non c'è più e alla cura di una studiosa che ha
pazientemente investigato nell'Archivio Historico Nacional di Madrid,
l'unico luogo al mondo dove ancora sono conservati i nomi dei martoriati
e dei condannati al rogo "in nome di Dio".
Dai graffiti di Palazzo Steri e dagli scritti della
ricercatrice Maria Sofia Messana si sta ricostruendo per la prima volta
quella che fu — dal 1500 al 1782—la pagina più dolorosa della
storia della Sicilia. Un incrocio di segni e di pitture e di vite che
fa riaffiorare dai muri dell'orrore la più cupa Palermo spagnolesca.
Un'impronta indelebile.
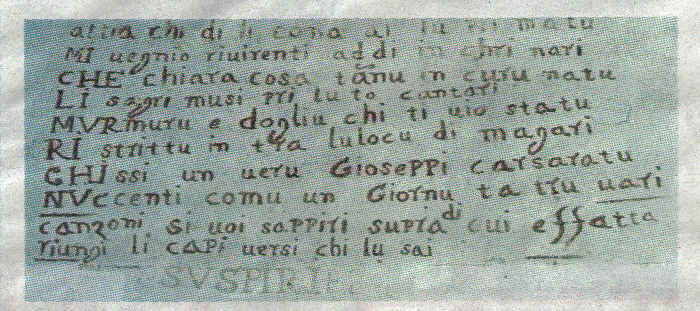
Cominciamo però da don Totò, pittoresco personaggio
dal quale parte inevitabilmente l'ultimo brano di questo romanzo lungo
più di quattrocento anni. Il suo vero nome era Salvatore Di Falco e anche
lui era nato, come il giovane pescatore Francesco Mannarino, fra
quell'ammasso di case basse davanti al porticciolo palermitano di
Sant'Erasmo. Si atteggiava a uomo "inteso" don Totò, uno di
quelli che nell'immediato secondo dopoguerra vantava protezioni
importanti. Qualcuno gli aveva anche fatto dono — diceva lui— di un
antico edificio proprio dietro allo Steri, un'area monumentale dove una
volta c'erano i magazzini dell'antico tribunale e la manifattura tabacchi.
Don Totò aveva messo in giro la voce che quella costruzione gliel'avesse
regalata il colonnello Charles Poletti in persona, il capo in Sicilia
dell'Amgot, il governo militare alleato dei territori occupati. In realtà
quell'edificio e il terreno circostante erano di proprietà
dell'Università di Palermo. Provarono, più volte e inutilmente, a
sfrattarlo. In Comune variarono perfino il piano regolatore, da lì
sarebbe dovuta passare una strada. Ma lì c'era il regno di don Totò.
L'Università entrò in possesso di ciò che le
apparteneva soltanto nel 2002, quando Salvatore Di Falco passò a miglior
vita per una crisi cardiaca. Dopo pochi giorni svuotarono i vecchi
magazzini. "Furono cinquantuno i camion con rimorchio stracarichi che
uscirono da quell'edificio trasformato in deposito", ricorda
l'ingegner Nino Catalano, direttore della divisione tecnica patrimoniale
dell'ateneo palermitano. Carcasse di auto, lapidi, copertoni, balle di
lana, divise militari, frigoriferi, lampade, sedie, caterve di legna,
materassi, ferraglia. L'ingegner Catalano si introdusse in quello che si
sarebbe disvelato come il Carcere della Penitenza seguendo le tracce di un
suo illustre parente — il suocero, avendone sposato una figlia—, che
tanti anni prima si era infilato proprio lì "quasi
clandestinamente". Era Leonardo Sciascia che stava per
scrivere l'opera a lui più cara, Morte dell'Inquisitore, il libro
sull'eretico di Racalmuto fra Diego La Matina che il 4 aprile 1657
fracassò il cranio al suo torturatore, "l'Illustrissimo signor don
Juan Lopez de Cisneros".
Così cominciarono, dopo la dipartita di don Totò, i
restauri dello Steri. E così apparvero i primi volti di Cristo, di
madonne, di angeli, di santi e di diavoli. Scritte color ocra, arancio, di
un giallo tenue o di un giallo forte che il tempo ha fatto diventare quasi
rosso. Poesie in dialetto, versi strazianti, tutte incisioni di tormento.
Ogni mese una piccola grande rivelazione, ogni mese un angolo di parete
che si colorava di più. Fino a quando, sul primo grande muro della prima
delle nove celle al pian terreno, vennero alla luce le prue delle galee
della battaglia di Lepanto. E poi, tra l'immagine di un vescovo e le vele
spiegate della Lega Santa e i vessilli con la mezza luna ottomana, si
mostrò quella firma, quel nome: Francesco Mannarino.
Chi era? E per quale "peccato" era stato
incarcerato nelle segrete di Palazzo Steri? Nel 1782 il governo illuminato
del viceré Caracciolo aveva cancellato, l'Inquisizione e, un anno dopo,ordinato
la distruzione di tutte le carte seppellite nel suo tribunale siciliano.
Un rogo purificatore. Per eliminare tracce di delitti e vergogne. E per
proteggete l'identità di sbirri e delatori compromessi nella mostruosa
macchina repressiva dei seguaci di Torquemada. Vi lavorarono in
quasi venticinquemila. Secondo alcuni storici, l'Inquisizione era potente
quanto Cia e Kgb insieme. Ma dei suoi crimini non c'erano più indizi: a
Palermo avevano bruciato tutto.
"E così, seguendo un suggerimento di Sciascia, sono andata a
Madrid", ricorda Maria Sofia Messana, la ricercatrice di storia
moderna che per la Sellerio ha appena finito di scrivere
"Inquisitori, Negromanti e Streghe.
Sarà in libreria a fine anno, è la scelta delle sue
documentazioni raccolte nell'Archivio Historico Nacional. È là che ha
trovato tutto quello che non c'è più in Sicilia sui martiri del Santo
Officio. È là, al Consiglio della Suprema, il Tribunale Generale
dell'Inquisizione, che ha trovato la "relacion de causa" di
Francesco Mannarino. Racconta: "Fu rapito insieme al padre, i pirati
trasportavano le loro vittime fra Algeri, Biserta e Costantinopoli. A
Francesco toccò il mercato degli schiavi di Biserta, dove lo comprò un
comandante che godeva fama di uomo malvagio. Solo dopo nove anni riuscì a
tornare a Palermo ma ormai, in quella città, Francesco era un musulmano.
Fu rinchiuso allo Steri, nella stessa cella di una delle tante vittime
delle spie prezzolate. Si chiamava Paolo Maiorana, era un ricco messinese
che ha lasciato anche lui un segno su quei muri. Una Madonna in lacrime.
C'è pure il suo fascicolo a Madrid, alla Suprema. Gravissimo il reato del
quale si era macchiato. "Aveva bestemmiato Gesù e la Madonna e aveva
detto "Santo Diavolo", un'evocazione del demonio", spiega
sempre Messana.
Nel 1601 Paolo Majorana entrò allo Steri la prima volta. Imbastirono un
processo ma la Suprema lo scarcerò: era accusato di blasfemia da un
testimone. Ma uno solo non bastava per il castigo. Ce ne volevano almeno
due. Nel 1609 lo trovarono. E riportarono Majorana un'altra volta allo
Steri. Ripescarono le vecchie carte e lo processarono ancora: nel 1618 fu
spogliato di tutti i suoi beni e mandato al remo per cinque anni.

Maria Sofia Messana trova certe assonanze fra le
antiche pratiche inquisitorie e certi moderni riti giudiziari: "Tutto
ciò che è accaduto a Paolo Majorana e a migliaia di prigionieri è di
sconcertante attualità: chi cade nelle mani di una mala giustizia spesso
non ha scampo". Molti sparirono all'improvviso. Dal 1623 al 1782 solo
a Palermo furono arsi in centottantotto, alla fine di lugubri
cortei che si concludevano con l' auto da fé " sulla passeggiata in
fondo alla marina. È lì che si accendevano i roghi. Bruciavano gli
uomini di "tenace concetto". Quelli che non si pentivano mai. O
i pazzi. Ma prima venivano torturati in quegli stanzoni appena riaperti e
dove c'è, proprio lì accanto, la sede del Rettorato.
Oggi il magnifico rettore dell'Università di Palermo, Giuseppe
Silvestri, la vuoi fare diventare una "città della cultura".
Spiega: "È stata un'emozione fortissima vedere affiorare dietro
l'intonaco, centimetro dopo centimetro, le testimonianze ancora intatte
dei prigionieri che hanno sofferto fra queste mura. Dopo secoli ci hanno
consegnato un'eredità che è insieme opera d'arte e atto di accusa verso
le ingiustizie del potere. I loro dipinti ci confermano che li dentro
furono imprigionati artisti, intellettuali, uomini scomodi".
A Palazzo Steri abitavano gli inquisitori, c'erano le
sale degli interrogatori e le cavità dove erano segregati i detenuti. Nel
restauro ogni ambiente sta prendendo forma. Le nove celle al pian terreno
e le altre nove sopra, le stanze trovate dietro quelle pareti alzate in
epoche successive, scale che scendono e salgono. "Qui è stato ucciso
l'inquisitore Juan Lopez de Cisneros", indica con la mano l'ingegner
Catalano mentre perlustra il cantiere. E proprio districandosi in quel
labirinto l'ingegnere ha fatto una scoperta nella scoperta: "Guardi
questo disegno di Renato Guttuso, è un'illustrazione per Morte
dell'Inquisitore, un libro che Sciascia ha scritto nel 1964". Il
disegno riproduce esattamente il luogo, così com'è nella realtà. Una
scala, la stanza degli interrogatori dove fra Diego La Matina colpì alla
testa l'Inquisitore, l'altra scala che si arrampica verso la sala del
Secreto.
Guttuso, già quaranta anni fa, aveva immaginato la
"scena del delitto" così come era avvenuta. Eppure queste
stanze e queste celle fino al 2004 erano ancora coperte dalle pietre,
soffocate nel tufo. "L'intuizione del genio", commenta incantato
Nino Catalano.
E poi, poi c'è un ultimo mistero in questa trama
infinita. Nell'illustrazione del pittore siciliano, il frate eretico di
Racalmuto uccise don Juan con i ceppi, battendoli ripetutamente sulla
fronte dell'Inquisitore. E così, in verità, era conosciuta la
"dinamica dei fatti" sino ad allora. Ma dalla Suprema di Madrid
è arrivata una rettifica ufficiale su come andarono le cose. In una
relazione che il nuovo inquisitore di Palermo Fabio Escobar inviava il
primo luglio 1657all'inquisitore generale Diego de Aize Reynoso, annotava
sull'assassino del suo predecessore: "Potentissimo signore,
partecipiamo a Vostra Altezza che l'alcalde delle carceri segrete salì di
mattina al tribunale e riferì che, avendo visitato quella mattina fra
Diego la Matina, recluso in dette carceri, lo aveva trovato senza manette,
che le aveva spezzate: manette che a causa della sua temerarietà il
tribunale aveva ordinato di imporgli...". Poi descrisse come fra
Diego uccise don Juan: "Prese uno strumento di ferro, che non è
stato possibile identificare per esservene diversi, e con esso diede
all'inquisitore Cisneros tre colpi sulla testa, due sul cranio...".
Chi aveva liberato il frate di Racalmuto? Chi l'aveva
lasciato senza ceppi, pur sapendo che qualche minuto dopo sarebbe stato
trascinato davanti al suo torturatore?
